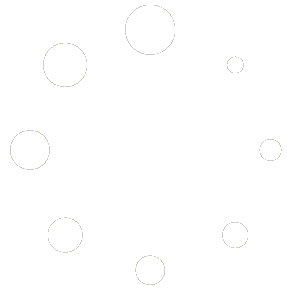20 Marzo 2020
Tali informazioni sarebbero estremamente preziose per studiare la propagazione dei virus e possibilmente per contenere l’epidemia
BRUXELLES. Negli ultimi giorni si è parlato molto di geo-localizzazione e tracciamento degli individui al fine di contenere l’emergenza del corona-virus. Si tratterebbe di sviluppare delle app estremamente precise in grado di registrare il percorso di individui infetti, il loro stazionamento in determinati luoghi e l’interazione con altre persone. Tali informazioni sarebbero estremamente preziose per studiare la propagazione dei virus e possibilmente per contenere l’epidemia. Si è fatto riferimento ai casi di cui abbiamo già notizia in Cina, Corea del Sud, Singapore ed Israele, dove tecnologie del genere sono già state testate, apparentemente con un certo successo (benché ancora non possiamo ancora essere sicuri al 100% della loro efficacia). Ad ogni modo, questi casi sono stati oggetto di dibattito perché tutti comportano una forte compressione della privacy, benché in misura diversa da paese in paese (in ragione dei differenti sistemi politici e giuridici).
La privacy, appunto. Non appena si è parlato di tracciamento dei singoli individui, e non di semplice raccolta di dati anonimi ed aggregati, in molti sono saltati sulla sedia constatando le implicazioni di un tale trattamento con la privacy. Giustamente, sia lo European Data Protection Board che il Garante Privacy italiano sono intervenuti per rammentare i limiti entro cui l’uso di una tale tecnologia si può muovere. Sui media però il tema si è incanalato su di un binario sbagliato: il problema sembrerebbe consistere in una sorta di ipotetica negoziazione tra coloro che difendono la privacy e quelli che invece vogliono combattere l’epidemia. Messa in questi termini, e facendo della privacy solo un problema nella lotta contro il corona-virus, l’esito è scontato: il comune cittadino al bar non ci pensa due volte a rinunciare alla privacy, visto che lo fa già molto spesso navigando in Internet per futili motivi, figuriamoci se non potrà farne a meno di fronte ad una tragedia, come quella del corona-virus, enorme in termini di perdita di vite umane e di cataclisma economico. Chiunque suggerirebbe di rinunciare alla privacy in tale contesto, ed il discorso su come contemperare i vari interessi in gioco rischierebbe di essere visto come un surreale esercizio accademico, avulso dalla tragedia che stiamo vivendo.
Il discorso deve pertanto essere risettato completamente: la normativa sulla privacy è sì un limite all’operatività delle app sul tracciamento individuale delle persone, ma è anche e soprattutto l’unica chance per far sì che tali app funzionino effettivamente e ci aiutino a raggiungere lo scopo, e cioè a sconfiggere l’epidemia. Mi spiego meglio.
L’efficacia delle app sul tracciamento individuale è legata alla loro adozione volontaria e diligente da parte delle persone, non certo ad una imposizione per legge. In un paese come l’Italia (ma anche in qualsiasi altra democrazia) sarebbe inconcepibile pensare di obbligare le persone a scaricare una certa app e tenere con sé sempre il cellulare. Al di là delle criticità giuridiche di un tale obbligo, c’è proprio un problema di fatto, si tratterebbe di un qualcosa troppo difficile da imporre in concreto e tempestivamente (soprattutto all’inizio di un fenomeno epidemico). Un cellulare può essere condiviso, intestato a terzi, lasciato a casa, disattivato, dimenticato o gettato via intenzionalmente, ecc. Neanche una dittatura sarebbe grado di imporre il rispetto di una tale obbligo, ed infatti persino in Cina, per quanto riguarda la sorveglianza di massa, si propende di più per il riconoscimento facciale.
Come fare quindi a convincere le persone ad adottare tali app ed usarle diligentemente? Come detto poc’anzi, tutti noi saremmo idealmente disposti a sacrificare la riservatezza dei dati personali in vista della potenziale salvezza della salute nostra, dei nostri cari e di qualsiasi altro. Tuttavia, al momento pratico, quando ci viene chiesto di farci “pedinare”, sorgono delle legittime domande: come verranno effettivamente usati i miei dati? Potrebbero essere condivisi con terzi per usi diversi? Qualsiasi ufficio dello Stato potrebbe averne accesso per verificare dove mi trovavo? Potrei subire un danno, una multa, una perdita per l’utilizzo dei miei dati per scopi differenti dalla lotta all’epidemia? Sono domande legittime che qualsiasi cittadino, senza particolari scheletri nell’armadio, si porrebbe lecitamente. Volgarizzando un po’, siamo tutti disposti a sacrificare la riservatezza di fronte allo Stato purché si tratti dei dati personali di qualcun altro. Ed infatti, quando realizziamo cosa significhi il nostro tracciamento individuale, e cioè l’essere noi seguiti dappertutto dall’occhio invisibile della Protezione Civile, a quel punto il valore dei nostri dati personali appare più chiaro. Persino quando si tratti delle stesse informazioni che normalmente si regalano per fare test improbabili su Facebook o farsi rimbalzare su Tinder.
Le regole sulla privacy intervengono proprio in questa fase. E’ in virtù di questa normativa misteriosa ed apparentemente elitaria che i dati raccolti con l’app di geolocalizzazione, che così tanto raccontano della nostra vita personale, verrebbero “blindati”. Come si sono sforzate di spiegare le varie autorità della privacy, l’articolo 15 della Direttiva europea ePrivacy prevede, se sono in ballo la sicurezza nazionale e pubblica, che lo Stato si attribuisca per legge l’eccezionale potere di pedinarci, ma che allo stesso tempo siano fissate una serie di garanzie a tutela dei cittadini: l’uso dei dati in questione dovrebbe essere eccezionale, giustificato per quanto riguardo la tipologia dei dati prescelti, limitato nel tempo, circoscritto nello scopo, e rafforzato da una serie di misure tecnologiche a difesa della sicurezza dei dati stessi. Gli stessi dati dovrebbero essere distrutti alla fine del processo, od eventualmente anonimizzati. Lo Stato come Google, in altre parole.
Questo è il lato un po’ paradossale della vicenda. Da anni esiste un mercato, più o meno autorizzato, dei dati di geo-localizzazione. Con il tempo operatori mobili, produttori di cellulari, piattaforme e app hanno raccolto una inusitata quantità di informazioni che è stata accumulata nei server per creare guadagno, e non certo per occupare spazio nei microchip. Solo per quanto riguarda i dati di geo-localizzazione, le informazioni che gli operatori mobili hanno di noi sono piuttosto importanti, mentre tale livello di informativa diventa terrificante nel mondo online, giacché app e piattaforme possono essere molto più precise delle celle telefoniche, raccolgono dati più sofisticati e per lungo tempo si sono mosse in un regime meno regolamentato (e forse ancora oggi). In altre parole, alcune multinazionali ed i loro clienti sanno moltissimo di noi grazie semplicemente ai dati di localizzazione: se abbiamo un amante, se siamo vegani o carnivori, se frequentiamo sale bingo o night club, se siamo sportivi o facciamo solo finta di esserlo (come il sottoscritto). Ma tutto ciò non ci ha mai creato grande sconforto, perché siamo abituati a fidarci più delle varie Maps che dello Stato. Quando però ci viene il dubbio che qualche funzionario statale possa sapere dove ci troviamo durante la giornata, a quel punto riscopriamo il valore della privacy. Ma tant’è. Non è questo il vero problema da sconfiggere in tempi di pandemia, il problema è sconfiggere la pandemia stessa, e la normativa sulla privacy è il solo strumento con cui lo Stato possa ragionevolmente convincere i cittadini a farsi pedinare con una app.
Fonte: La Stampa – Esteri